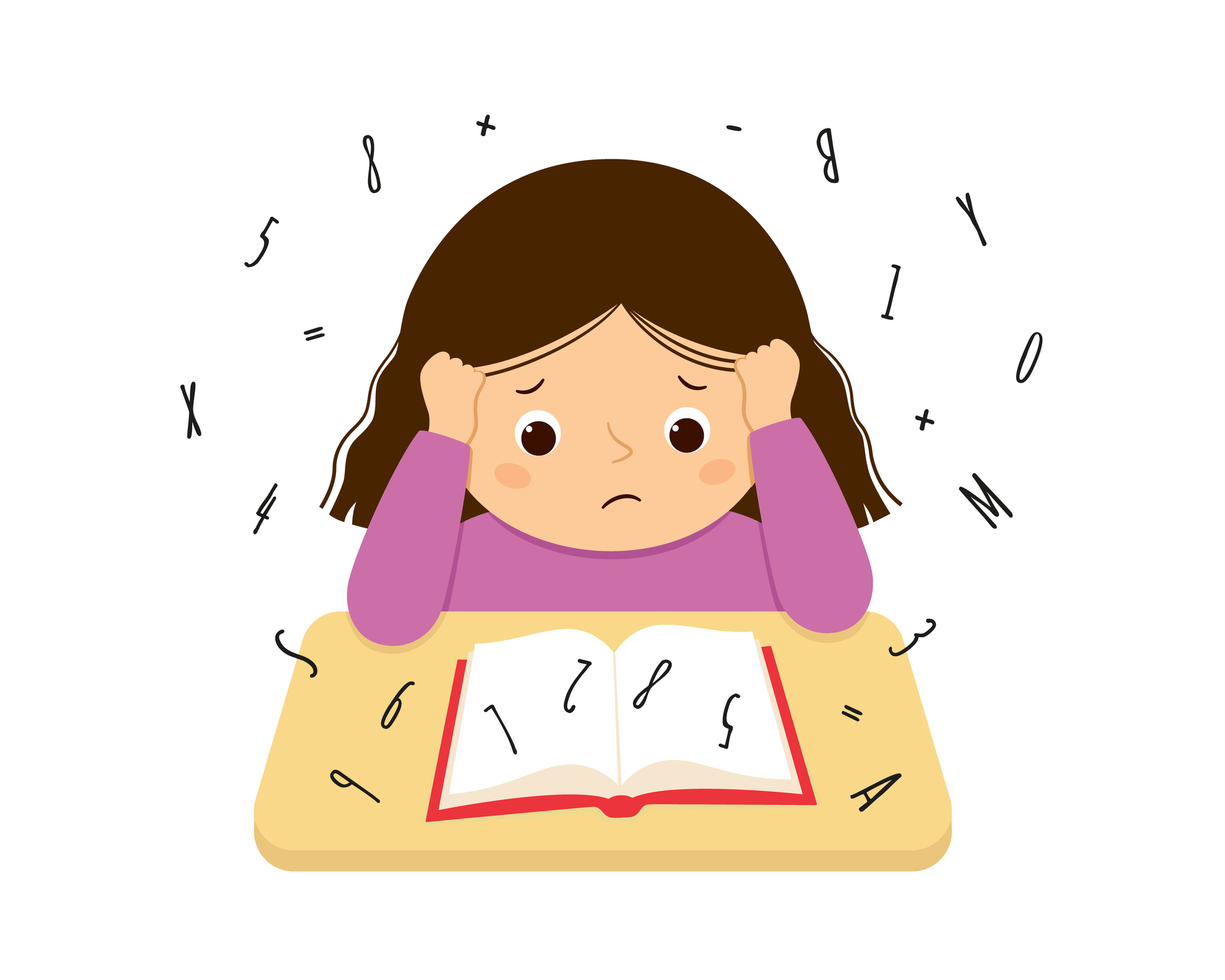Con il passaggio dall’ora solare a quella legale le giornate iniziano dopo ma durano di più. Tuttavia, la minore esposizione alla luce del mattino (associata ad una maggiore esposizione alla luce serale), potrebbe provocare, specie nei primi giorni, perdita di sonno e sonnolenza diurna.
Inoltre, secondo alcuni studi, il cambio dell’ora primaverile è associato ad un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, come l’infarto del miocardio, l’ictus ischemico e la fibrillazione atriale, oltre a disturbi dell’umore e pensieri suicidari.
Dal punto di vista biologico, invece, il passaggio all’ora legale potrebbe alterare i ritmi dell’orologio biologico circadiano. Questo ritmo è fondamentale per il benessere, poiché regola una serie di processi biologici, tra cui le risposte immunitarie, lo stress ossidativo e l’infiammazione[1].
Ce ne parlano la dott.ssa Gabriella Comerio, cardiologa presso l’ambulatorio Humanitas Medical Care Domodossola a Milano e il dott. Alessandro Spiti, psichiatra di Humanitas PsicoCare.
Quali sono le cause degli eventi cardiovascolari durante il cambio dell’ora?
“Il sistema cardiovascolare è strutturato per affrontare oscillazioni nell’arco della giornata; il ritmo circadiano è importante per il benessere dell’individuo perché regola numerosi processi biologici, tra i quali lo stress ossidativo, i processi infiammatori, la risposta immune ed altri”, commenta la dott.ssa Comerio.
“Alcune malattie cardiovascolari”, continua la specialista, “si manifestano in particolari momenti della giornata: ad esempio, l’incidenza degli infarti miocardici, di eventi ischemici cerebrovascolari, rottura di aneurismi aortici, di fibrillazione atriale ed altri sembra essere più alta al mattino.
Questo fenomeno può essere giustificato da meccanismi fisiologici che avvengono alle prime ore della mattina, come ad esempio l’incremento della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca dell’attività simpaticomimetica, della secrezione di ormoni vasoattivi ed anche della aggregabilità piastrinica.
Il cambio dell’ora causa una variazione del ritmo circadiano e non tutti i soggetti sono in grado di affrontare questa variazione senza effetti sul proprio organismo.
Precedenti pubblicazioni avevano osservato un incremento di eventi cardiovascolari nei giorni successivi al cambio dell’ora; lavori scientifici più recenti ed una interessante metanalisi (Manfredini et al.) hanno confermato un modesto incremento del rischio di infarto miocardico nella settimana successiva al cambio dell’ora in primavera, senza una sostanziale differenza tra i due sessi; tuttavia l’interpretazione di questa osservazione non sarebbe forse da attribuire univocamente al cambio dell’ora.
È necessario anche sottolineare che gli studi analizzati presentano differenze di popolazione osservata (aree geografiche e cronobiologiche diverse, es. USA ed Europa) e diversi criteri di inclusione di eventi cardiovascolari (es. infarti miocardici con e senza interventi di angioplastica)”, conclude la specialista.
Chi sono le persone più a rischio di eventi cardiovascolari durante il cambio dell’ora?
“Sembra che siano più suscettibili ad eventi sfavorevoli, non solo di tipo cardiovascolare, i soggetti più anziani (>75 anni), i soggetti in condizioni di salute più fragile e coloro che hanno più patologie”, risponde la dott.ssa Comerio; “negli Stati Uniti un recente studio osservazionale ha segnalato come più a rischio di eventi sfavorevoli anche i soggetti caucasici non ispanici e i coloro che vivono nelle zone con fuso orario orientale[2]”.
Quali effetti può avere la privazione del sonno legata all’ora legale?
“Le persone che non riescono a dormire a sufficienza hanno maggior difficoltà a prendere decisioni e sono meno creative ” commenta il dott. Spiti. “Inoltre, sono più inclini a provare stati d’animo negativi; hanno maggiori probabilità di sperimentare angoscia , manifestando un minor coinvolgimento nella dimensione lavorativa con prestazioni al di sotto delle aspettative personali e del team.
Le persone con alterazioni del pattern ipnico corrono un rischio maggiore di mettere in atto comportamenti pericolosi che possono determinare infortuni ed incidenti automobilistici[3].
Inoltre, una componente importante di molti disturbi dell’umore, d’ansia e psicotici è proprio l’interruzione del ciclo sonno-veglia [4] (alcuni disturbi del sonno, in particolare della fase REM, sono stati osservati nel disturbo bipolare (BD) e nella schizofrenia [5].
I disturbi del sonno e le alterazioni circadiane sono associati anche a disturbi del neuro-sviluppo, come il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), i disturbi dello spettro autistico (ASD), la sindrome di Prader-Willi (PWS) e la sindrome di Smith-Magenis (SMS) [6]”,conclude lo psichiatra.
Come alleviare i sintomi del cambiamento dell’ora?
“Il cambio dell’ora può avere un impatto sul nostro benessere e sulla routine quotidiana”, continua il dott. Spiti. “Per attenuare i sintomi di questo cambiamento, è possibile adottare alcune strategie pratiche.
In primis, è consigliabile iniziare gradualmente a prepararsi al nuovo orario, modificando leggermente la propria routine del sonno e altri ritmi biologici qualche giorno prima del cambio effettivo, andando a letto dieci minuti prima e anticipando leggermente il risveglio. Questa piccola modifica, assieme al mantenimento di una routine costante, inclusi gli orari di sonno e dei pasti, può aiutare il corpo a stabilizzarsi più facilmente.
Un altro consiglio è limitare il consumo di sostanze stimolanti come la caffeina che nelle ore precedenti il riposo possono alterare il profilo del sonno, determinando fenomeni nel giorno successivo quali astenia, irritabilità e problemi di concentrazione. Infine, l’esposizione alla luce solare durante il giorno favorisce l’attivazione di alcune regioni del cervello, come l’ipotalamo, che sono fondamentali per regolare positivamente l’adattamento del nostro organismo al nuovo orario.
Se si riscontra una difficoltà significativa nell’adattamento al nuovo orario o se i sintomi persistono, è opportuno considerare il supporto di un professionista della salute mentale”, conclude lo specialista.
Le giornate più lunghe aiutano l’umore?
“La correlazione positiva tra esposizione alla luce solare (foto-esposizione) e miglioramento dell’umore ormai è dimostrata e confermata da numerosi studi scientifici [7;8;9]”, aggiunge il dott. Spiti. “Le variazioni del fotoperiodo, ovvero della durata del periodo di illuminazione giornaliera, possono incidere sensibilmente sullo stato d’animo delle persone, soprattutto di quelle che sono suscettibili maggiormente allo sviluppo di veri e propri disturbi dell’umore. Solitamente, infatti, questo tipo di persone soffrono di episodi depressivi stagionali, nella fase in cui il fotoperiodo si accorcia nel passaggio dalla stagione autunnale a quella invernale. Al contrario, nei mesi in cui il fotoperiodo si allunga, nel passaggio dall’inverno ai mesi caldi, si assiste a un graduale incremento delle energie, con progressivo recupero del piacere durante le attività quotidiane e scomparsa dei sintomi depressivi.
Il meccanismo biologico che media queste variazioni si basa sull’interazione tra varie aree del nostro cervello.
La luce solare penetra attraverso la retina dell’occhio e attiva le cellule fotosensibili, che trasmettono segnali al nucleo soprachiasmatico nell’ipotalamo, coinvolto nella regolazione del ritmo circadiano. Questo nucleo ipotalamico invia segnali a diverse regioni cerebrali coinvolte nella produzione di monoamine. La serotonina è sintetizzata principalmente nel nucleo del rafe, la noradrenalina nel locus coeruleus e la dopamina nel sistema dopaminergico. L’esposizione alla luce solare stimola l’attività di queste regioni, promuovendo la produzione e il rilascio di serotonina, noradrenalina e dopamina nel cervello.Questi neurotrasmettitori svolgono ruoli distinti ma interconnessi nella regolazione dell’umore, delle emozioni e della motivazione. La serotonina è spesso associata al benessere emotivo, la noradrenalina alla risposta allo stress e all’attenzione, mentre la dopamina al sistema di ricompensa e al piacere. In sintesi, l’esposizione alla luce solare, può attivare la produzione di monoamine nel cervello, contribuendo così a migliorare l’umore e il benessere emotivo attraverso l’azione combinata di serotonina, noradrenalina e dopamina”, conclude lo specialista.
Trova lo specialista che fa per te
BIBLIOGRAFIA
[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10921520/
[2] Circadian Mechanisms in Medicine; R. Allada et al; N Eng J Med 2021; 384: 550-61 – Daylight Saving Time and acute myocardial infarction: a meta-analysis; R. Manfredini et al; Journal Clinical Medicine; 2019, 8, 404 – Daylight saving Time does not seem to be associated with number of percutaneous coronary interventions for acute myocardial infarction in the Netherlands; L.Derks et al; Neth Heart J 2021; 29: 427-432 – All cause and cause specific mortality associated with transition to daylight saving time in US: nationwide, time series, observational study; Shi Zao et al; BMJmedicine 2024; 3: e000771
[3] Kilgore, Balkin e Wesensten, 2006; Harrison e Horne, 1999; Dinges et al., 1997; Glozier et al., 2010; Lanaj, Johnson e Barnes, 2014; Drake et al., 2001; Barnes & Wagner, 2009; Drake et al., 2010
[3] https://www.humanitas-care.it/news/la-privazione-del-sonno-influisce-sulla-salute-del-cuore/
[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6338075/
[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20686197/
[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6338075/
[7] Siemann, J. K., Grueter, B. A., & McMahon, D. G. (2021). Rhythms, reward, and blues: consequences of circadian photoperiod on affective and reward circuit function. Neuroscience, 457, 220-234. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030645222030779X
[8] Majrashi, N. A., Alyami, A. S., Shubayr, N. A., Alenezi, M. M., & Waiter, G. D. (2022). Amygdala and subregion volumes are associated with photoperiod and seasonal depressive symptoms: A cross‐sectional study in the UK Biobank cohort. European Journal of Neuroscience, 55(5), 1388-1404. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ejn.15624
[9] Partonen, T. (2020). Seasons, Clocks and Mood. Neuroendocrine Clocks and Calendars, 177-187. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-55643-3_9